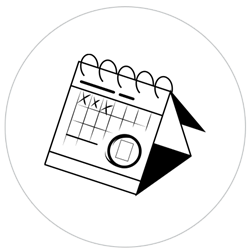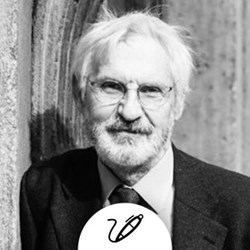Anniversari e Ricorrenze
Un dio da stringere e amare: Giovanni Testori

Illustrazione digitale di Francesco Vercesi, diplomato al Liceo Artistico Volta di Pavia, 2023
Riandando, a cent’anni dalla nascita, alla figura di Giovanni Testori, protagonista della cultura letteraria e artistica della seconda metà del Novecento, si fatica a trovargli una centralità irradiante, quasi, a ogni svolta della sua immaginazione e dei suoi studi, il centro si spostasse, accendendo fuochi di attenzione, di segni lasciati, di segni forti (nella pittura, nella critica d’arte, nel teatro, nella narrativa, nella poesia), dettati da una irrequieta fame di esperienza e di espressione.
E c’è voluto tempo per avvertire la tortuosa continuità di quei segni, la consequenzialità torrentizia delle “prove” dentro il destarsi quaresimale di una voce franta, alta, artigliata a un cielo grave di azzurro e di nubi come quello del “suo” Gaudenzio Ferrari.
Le piaghe sulle quali si attarda, negli studi sulla pittura lombarda fra Cinque e Seicento, le ferite illuminate da anatomica empietà, hanno detto, con tremore e scandalo, con non mai distratta severità, dove il corpo (anche il corpo sociale) si allaccia all’anima (anche all’anima di un popolo). Se ha cercato nel romanzo e nel teatro i “segreti” di una città come Milano, lo ha fatto spingendo innanzi personaggi in attesa di dolore. Se questa prima fase della sua aggressione alla parola drammaturgica e narrativa è stata – e lo è stata – così incisiva, si ha ben ragione di pensare che era cominciata in Testori una rivolta interiore, che ha avuto bisogno di una “scena” lontana dalle certezze della sua classe di appartenenza, e dal cattolicesimo della famiglia di origine (i Testori sono industriali del tessile).
La Gilda del Mac Mahon, L’Arialda, La Maria Brasca e gli eroi vallassinesi (del Dio di Roserio, e della Maria di Barni) non vengono né da una tradizione verista-vernacolare (ma non si dimentichi che nel 1955 va in scena El nost Milan diretto da Giorgio Strehler) né dal neorealismo (quello si era inventato, nel cinema, una strada unica di narrazione). Quelli di Testori sono piuttosto fantasmi evocati da una periferia barbarica, antropologicamente “antica” e feroce, da una immaginazione volutamente stracciata – e quando, molto più tardi, arriva con la Trilogia degli scarozzanti la mescidata contaminazione di dialetto e “lingue morte e agonizzanti” si comprende ancor meglio qual era il destino della voce che andava cercando anche nelle prime opere.
Non è un caso che Luchino Visconti si ispiri a quei fantasmi per il suo melodramma sociale, Rocco e i suoi fratelli, dove si leva la nebbia “rocchina” (così nel bellissimo volume Luchino, uscito postumo per Feltrinelli solo nel 2022, grazie alla cura di Giovanni Agosti), dove brucia la violenza che martirizza i corpi fra il ring e i marciapiedi della Ghisolfa, dove si monumentalizza il gesto tragico di una madre del Sud, dove l’amore “idiota” di Rocco si traduce in sacrificio e condanna.
Cronaca? No. Se non delle anime. Quand’anche Testori sente di star parlando di una Milano nuova, sporca, ingiusta, immalinconita dal male, la sua rappresentazione sborda verso l’evidenza di un orizzonte più vasto. E vasto è quello che persegue attraverso la pittura (quella agita e quella studiata). E qui ci sono pertinenti ossessioni. Prima fra tutte quella per il Caravaggio e i caravaggeschi (decisivo l’incontro con Roberto Longhi, complice la grande mostra del 1951 a Palazzo Reale), Gaudenzio Ferrari, il Cerano, Tanzio, e massimamente il Sacro Monte di Varallo.
E infatti, dopo il ’60 – dopo quella grande stagione di racconti e sfide drammaturgiche –, c’è un silenzio colmato dagli studi critici d’arte che sfolgorano in uno dei suoi capolavori, Il gran teatro montano. Saggi su Gaudenzio Ferrari (1965, ripubblicato da Feltrinelli a cura di Giovanni Agosti nel 2015) e dal poema I trionfi (1965), dilagante e franante altare barocco al corpo dell’amore e ai corpi di Théodore Géricault. Tanto I trionfi restò ai confini della ricezione letteraria – il verso gioca deliberatamente con il molto, addirittura con il troppo –, tanto, otto anni più tardi, Testori si lasciò intendere con quasi agghiacciante limpidezza disegnando il compatto calvario liberatorio di Nel tuo sangue (1973), a mio avviso la sua più grande sfida etica ed estetica, sospesa fra blasfemia e religiosa perdita di sé.
All’insegna di una schieratissima posizione spirituale e politica, l’opera successiva si muove fra abbandono, rabbia e pietas nel territorio del lutto privato (la morte della madre) e pubblico (la società moribonda in cui fatica a riconoscersi). Resta lo strappo incandescente davanti a Dio che, nel cuore dei versi di Nel tuo sangue, segna indelebile l’ustione di un’anima non mai veramente (e fortunatamente) pacificata:
T’ho amato con pietà / con furia T’ho adorato. / T’ho violato, sconciato, / bestemmiato. // Tutto puoi dire di me / tranne che T’ho evitato
Per festeggiare i cento anni di Testori
Gli altri approfondimenti

La posta della redazione
Hai domande, dubbi, proposte? Vuoi uno spiegone? Scrivi alla redazione!
Conosci l'autore
Per poter aggiungere un prodotto al carrello devi essere loggato con un profilo Feltrinelli.
Per poter aggiungere un prodotto alla lista dei desideri devi essere loggato con un profilo Feltrinelli.
Il Prodotto è stato aggiunto al carrello correttamente
Il Prodotto è stato aggiunto alla WishList correttamente