10 libri sul comò
Il dialetto milanese nei libri
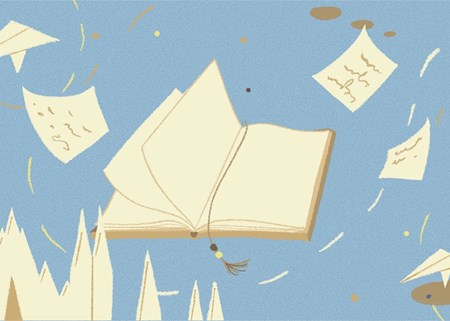
Illustrazione digitale di Sofia De Camillis, 2023, studentessa presso l'Istituto Europeo di Design di Milano
Milano è una delle città più importanti d’Italia, secondo comune più popoloso della nostra nazione e quinta meta turistica in Europa. È una metropoli, una città viva, in continuo mutamento, che non dorme mai. È la città più che viene maggiormente scelta dai giovani italiani che vogliono trasferirsi.
Un luogo dove i sogni, le ambizioni, i progetti possono realizzarsi. Tanto frenetica, contemporanea e glamour quanto ricca di storia, cultura e radici.
Fondata da una tribù celtica nel 590 a.C. e, secoli dopo, conquistata dai Romani fino a diventare Capitale dell’Impero Romano d’Occidente.
Proprio a seguito delle sue dominazioni, il dialetto parlato dai milanesi è una commistione di diversi idiomi. Un misto tra il gallico e il longobardo a cui si aggiungono le influenze della lingua spagnola durante il dominio iberico sul Ducato di Milano (dalla metà del 1500 circa).
Durante l’Illuminismo si arricchisce ulteriormente di lemmi derivanti dalla lingua francese a seguito delle invasioni napoleoniche.
Con l’unità d’Italia, nel 1861, la lingua lombarda affronta il suo processo più radicale perdendo molte delle sue caratteristiche a favore della lingua italiana.
Nonostante le continue incursioni di altre lingue, il dialetto milanese è sopravvissuto. L’Unesco ne registra, tuttavia, il pericolo di estinzione, essendo parlato da un numero sempre minore di persone. Ad oggi, risulta ancora in uso a Milano, nella provincia di Monza-Brianza, Varese, Como e Pavia.
Milano è la sede di tantissime case editrici e di sicuro una delle città in cui si ambientano molti romanzi. Per questo non stupisce che il dialetto milanese abbia una tradizione importante anche nei testi scritti.
Fin dal XIII secolo è stato usato per giungere al maggior numero di persone possibile, preferito al latino medievale.
Uno dei maggiori esponenti del dialetto milanese in letteratura è stato Carlo Maria Maggi, che nel ‘600 con testi teatrali e poetici riuscì a tenere testa all’ormai dilagante “modello fiorentino” proponendo opere vicine al vivere civile in netta contrapposizione con lo stile barocco.
A lui si deve anche l’altro termine in uso per distinguere tutto quello che riguarda Milano, in particolare il dialetto, ovvero la parola “meneghino”.
“Meneghino” è un personaggio del teatro milanese da lui inventato divenuto successivamente una maschera della commedia dell’arte. Rappresenta un servo fedele, schietto e laborioso con spirito di accoglienza e benevolenza. É una persona cordiale e ospitale e molto dedita al lavoro.
Non si può parlare di letteratura dialettale milanese senza citare Carlo Porta, senza dubbio il maggior poeta in milanese, la cui più importante caratteristica è la capacità di rappresentare con realismo, nei suoi poemetti milanesi, i rapporti all’interno della società.
Carlo Porta muore nel 1821. Sono questi gli anni in cui Alessandro Manzoni è alle prese con la seconda stesura di quello che diventerà I promessi sposi.
Citiamo quanto riportato nella prefazione di Enrico Ghidetti dell’opera edita Feltrinelli: riferendosi alla lingua scelta per la stesura il Manzoni la giudica “un composto indigesto di frasi un po’ lombarde, un po’ toscane, un po’ francesi, un po’ anche latine”. Sconfortato Manzoni la definisce “cattiva lingua”. Alla fine, sceglie per il suo manoscritto il fiorentino parlato dalle classi colte, così da poter essere letto e compreso da un numero maggiore di persone.
Nonostante ciò nella sua opera Sentir messa, Alessandro Manzoni riferisce che il suo dialetto milanese sarebbe stato la lingua più adatta a diffondersi in tutta Italia in quanto lingua viva, perché parlata, rispetto al fiorentino scritto. Per questo decise di scrivere I promessi sposi nel fiorentino parlato che riteneva, allo stesso modo, lingua viva.
In epoca contemporanea continua ad esserci una produzione di testi contaminati dal dialetto milanese e soprattutto vengono tradotti in dialetto alcuni classici stranieri come Il piccolo principe (El principe piscinin).
Di certo autori quali Scerbanenco, Dario Fo, Andrea Pinketts hanno attinto, per le loro opere, al dialetto milanese facendolo utilizzare ai loro personaggi, resi così caratteristici e indimenticabili.
I loro libri si inseriscono nella grande tradizione scritta milanese, i cui autori restano saldamente sugli scaffali delle librerie a rappresentare la cultura milanese per eccellenza.
Non possiamo non rivolgere un piccolo pensiero anche alla forte presenza del dialetto milanese nell’arte musicale, citando il grande Enzo Jannacci.
Ci si augura che si possa leggere sempre più spesso libri in “dialetto milanese” affinché il pericolo di estinzione palesato dall’Unesco non si verifichi ma, anzi, venga del tutto confutato.
Gli altri 10 libri sul comò

La posta della redazione
Hai domande, dubbi, proposte? Vuoi uno spiegone? Scrivi alla redazione!
Per poter aggiungere un prodotto al carrello devi essere loggato con un profilo Feltrinelli.
Per poter aggiungere un prodotto alla lista dei desideri devi essere loggato con un profilo Feltrinelli.
Il Prodotto è stato aggiunto al carrello correttamente
Il Prodotto è stato aggiunto alla WishList correttamente







